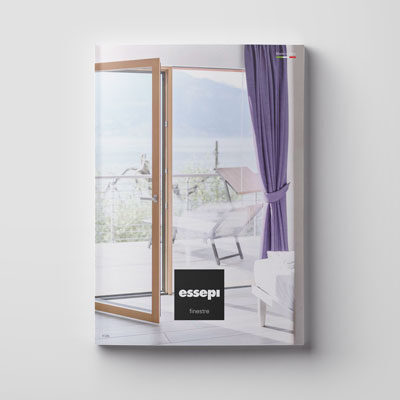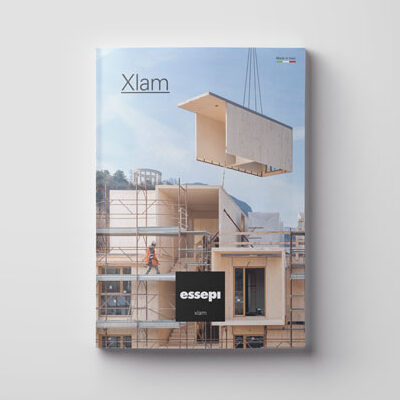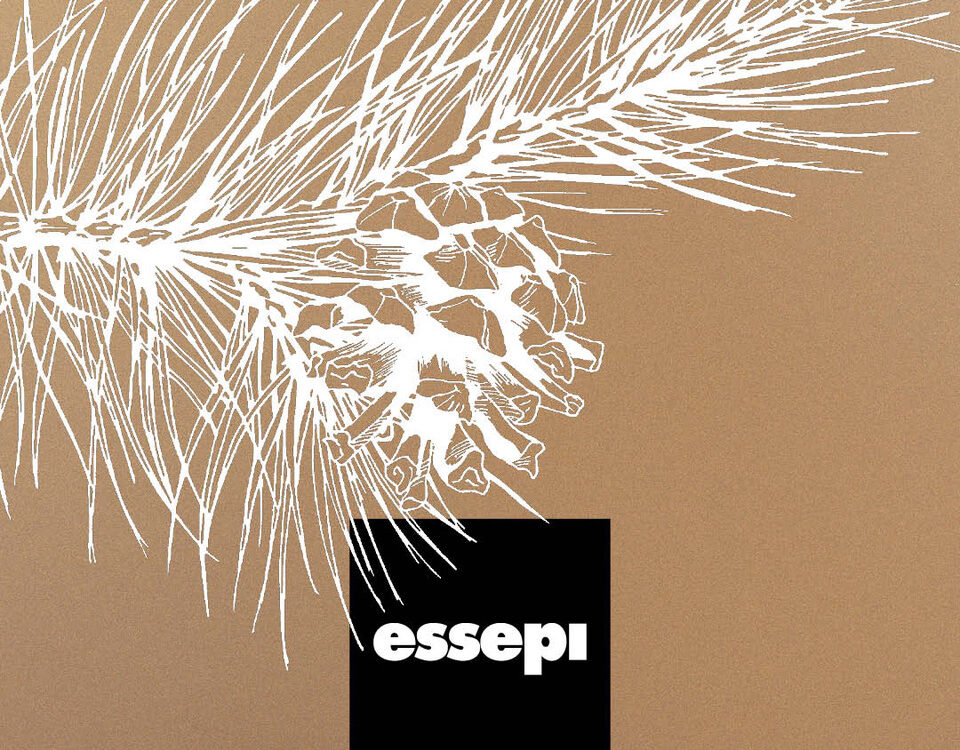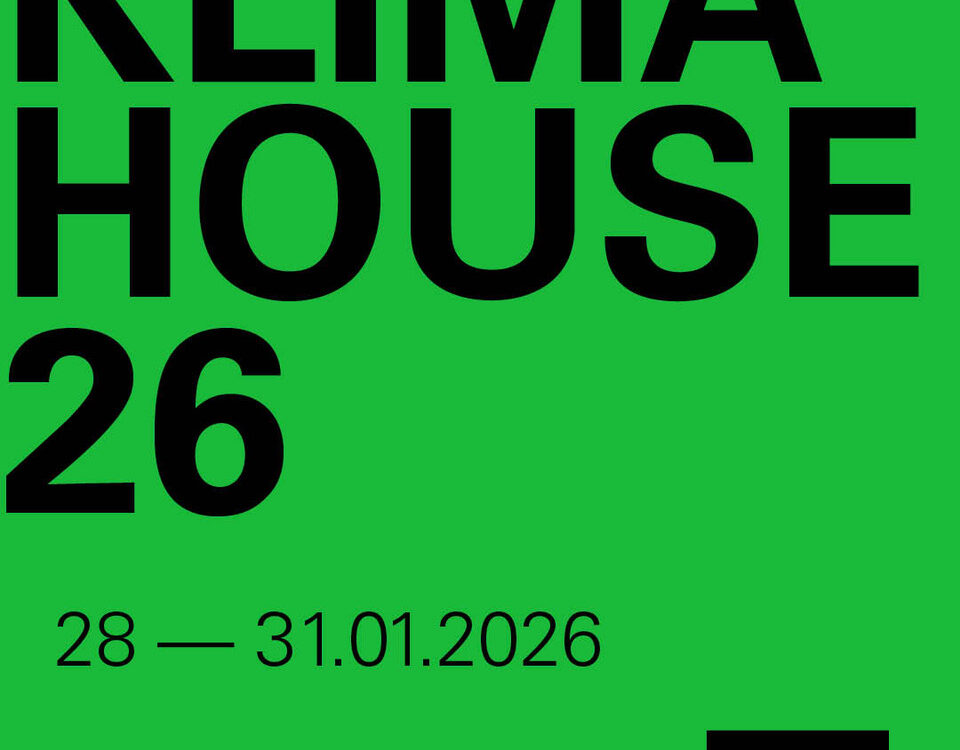Che cos’è quel filo verde, tenue ma tenace, che si sta intrecciando all’acciaio e al cemento in alcune delle nostre città? È il design biofilico, una filosofia, un approccio all’architettura che vuole riconnettere la natura allo spazio costruito per migliorare il benessere, la salute fisica e mentale, la creatività, la produttività delle persone.
Il termine “biofilia” (amore per la vita) è stato coniato dallo psicologo sociale Eric Fromm (1964) e successivamente reso popolare dal biologo Edward O. Wilson (1984). Varie sono le definizioni che si sono sviluppate dal campo della biologia e della psicologia e che sono state adattate ai campi delle neuroscienze, dell’endocrinologia fino all’architettura; tutte si ricollegano al desiderio di una riconnessione con la natura e i sistemi naturali in quanto l’uomo è geneticamente predisposto a prediligere determinati tipi di scenari naturali e ciò è il risultato di millenni di adattamento all’ambiente. Il nostro equilibrio, il nostro benessere psicofisico e la nostra salute dipendono dal grado di connessione con (o, per contro, dalla distanza da) elementi naturali. Calo di attenzione, stress, affaticamento, depressione, bassa produttività sono anche effetti negativi di quello che il pedagogista statunitense Richard Louv ha descritto come “disturbo da deficit di Natura” e che si manifesta soprattutto vivendo, fin da bambini, al chiuso e in ambienti urbani sempre più densi.
La presenza di temi naturali nelle strutture e nei luoghi fin dall’antichità – che fossero abitazioni, luoghi pubblici, privati o di culto – suggerisce che la progettazione biofilica non è un fenomeno nuovo. I giardini pensili di Babilonia, una delle sette meraviglie del mondo antico, rappresentano un esempio emblematico di integrazione tra natura e spazio costruito (ai quali, d’altronde, si sono ispirati anche gli architetti dello studio Boeri per il loro pluripremiato Bosco verticale di Milano). Allo stesso modo, le ville rinascimentali, che erano concepite con una forte armonia tra architettura e paesaggio, spesso circondate da giardini geometrici e percorsi d’acqua. Nel XIX e XX secolo, l’Art Nouveau ha celebrato la fusione tra arte e natura, incorporando linee organiche e motivi ispirati a fiori, foglie e forme animali in architettura, mobili e decorazioni. Anche le tradizionali case giapponesi, con i loro giardini zen e le porte scorrevoli che aprono lo spazio interno alla natura, incarnano una visione biofilica ante litteram. Che parta dall’intuizione umana o, in anni recenti, dalle neuroscienze, è chiara l’indicazione che le connessioni con la natura sono vitali per mantenere un’esistenza sana per la nostra specie.
Architettura biofilica: la risposta progettuale
Gli spazi progettati secondo i principi della biofilia, che siano abitazioni, luoghi di lavoro, spazi ricreativi, educativi, strutture ricettive o sanitarie, non si limitano a imitare la natura, ma la mettono in connessione con gli edifici di cui facciamo esperienza quotidianamente. Le piante, il verde, la luce, l’acqua, i materiali naturali non sono più solo elementi estetici, decorativi, optional, ma diventano co-protagonisti dell’ambiente in cui viviamo, lavoriamo, trascorriamo del tempo. Stephen R. Kellert è una figura centrale nello sviluppo e nella promozione del design biofilico. Professore e ricercatore presso l’Università di Yale, ha dedicato gran parte della sua carriera a esplorare la connessione tra natura, ambiente costruito e benessere umano, consolidando i principi fondamentali che guidano questo approccio progettuale ed enucleando diversi meccanismi che possono generare un’esperienza biofilica. Il suo approccio è definito olistico poiché simula le qualità spaziali di determinati ambienti naturali, le loro forme e materiali, per stimolare risposte positive del corpo umano.
I principi chiave, o pattern, della progettazione biofilica si possono riassumere nel progettare con la natura. Da decenni, ricercatori, neuroscienziati, e professionisti della progettazione lavorano per definire gli aspetti della natura che influiscono maggiormente sul nostro gradimento dell’ambiente costruito. Ne citiamo solo alcuni. In primis, la presenza diretta, fisica della natura in uno spazio o in un luogo come la connessione visiva con la natura, data da finestre panoramiche, cortili interni, aree verdi visibili, aree living all’aperto, la fluidità interno-esterno. Poi l’inserimento di “analoghi naturali” quali la ventilazione dinamica, il coinvolgimento e gli stimoli multisensoriali sonori, olfattivi, visivi come il rumore dell’acqua, il profumo del legno, la gestione variabile della luce. E ancora: l’uso di materiali naturali, autoctoni e sostenibili, la riproposizione di forme organiche e modelli del mondo naturale, come superfici curve e arrotondate e geometrie naturali, fino all’uso della prospettiva e la realizzazione spazi “rifugio”. Questi sono luoghi protetti (di studio, relax, meditazione), ma connessi con l’esterno (motivati dall’esigenza primordiale di avere luoghi che garantiscano una visuale ampia, per identificare possibili minacce, e, allo stesso tempo, offrano una barriera fisica o visiva, per sentirsi al sicuro). Non solo l’architettura, ma anche il design può ispirarsi alla biofilia con pareti verdi e viventi, materie naturali di provenienza autoctona, fibre naturali, forme organiche, modelli, colori e trame ispirati alla natura, e, ça va sans dire, materiali sostenibili. La progettazione biofilica è una progettazione fatta per l’essere umano quale organismo biologico, nel rispetto dei sistemi corpo-mente che sono indicatori di salute e benessere e deve essere appropriata rispetto al luogo e al contesto.
I benefici misurabili
I vantaggi della progettazione biofilica sono oggetto di numerose ricerche nate dalle intersezioni tra neuroscienze e architettura. Gli studi di Terrapin, Bright e Green (2014) dimostrano l’impatto positivo di tale approccio sul benessere fisico e mentale, sulle prestazioni cognitive, sulla produttività, l’umore, le emozioni, l’affaticamento, le prestazioni creative, la riduzione dello stress, concentrazione e rigenerazione della memoria fino al recupero fisico. Alcuni esempi tra i tanti. Fin dagli anni ’80 le ricerche di Ulrich condotte negli ospedali, spiega Totaforti, direttore del Centro studi che ha progettato il primo giardino terapeutico d’Italia presso il Policlinico Gemelli di Roma, hanno dimostrato come “la semplice visione del verde da una finestra fosse in grado di accorciare i tempi di guarigione post-operatoria e di diminuire il fabbisogno di antidolorifici. Gli interventi di design biofilico in contesto ospedaliero, molto praticati all’estero, partono da quelle acquisizioni e si fondano oggi su oltre quarant’anni di studi internazionali”. In ambito educativo, Barbiero e Berto dell’Università della Valle d’Aosta hanno osservato che la ricreazione degli studenti svolta in ambienti naturali, come una passeggiata nel verde, accelera la rigenerazione dell’attenzione del 30% in più, rispetto allo stesso free time trascorso tra i banchi.
Non solo edifici: un mondo sostenibile
Un aspetto non trascurabile è quello della sostenibilità. Gli edifici che incorporano il design biofilico usano materiali sostenibili, sono meno energivori e sono progettati per ridurre gli sprechi. Questi edifici possono avere un impatto ambientale positivo, generando energia propria e arricchendo le riserve idriche. In un’epoca di cambiamento climatico e crescente urbanizzazione, anche il design biofilico rappresenta uno stimolo ulteriore a ripensare il modo in cui viviamo e costruiamo. Il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso sta collaborando con l’architetto giapponese Kengo Kuma alla progettazione di Welcome, un importante complesso biofilico a Milano: un edificio in legno, con piazze e corti verdi, sentieri rialzati, tetti coperti di vegetazione, orti e piante. Mancuso sostiene che “le piante oggi dovrebbero far parte di qualunque processo progettuale che si voglia serio”. La superficie occupata dalle città sul pianeta è intorno al 2% delle terre emerse, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP): da questa minuscola area proviene il 70% della CO2, l’80% dei rifiuti prodotti dal pianeta, le bolle di calore. Occorre cambiare la nostra idea di città, sostiene Mancuso, che deve essere compatibile con l’ambiente: grandi risultati possono essere raggiunti semplicemente utilizzando e introducendo le piante nei luoghi della vita urbana, strade, piazze, edifici. “La città del futuro dovrebbe essere costruita con ponti che permettano alla natura di entrare”.
Criticità e limiti
Il design biofilico offre molteplici benefici, ma non è privo di sfide. L’integrazione di elementi naturali richiede spesso investimenti iniziali più alti rispetto a soluzioni convenzionali, sia per i materiali sostenibili che per le tecnologie necessarie. Inoltre, la manutenzione degli spazi verdi, come giardini verticali o tetti vegetali, comporta spese periodiche e una gestione specializzata. In aggiunta, l’adozione di un approccio biofilico presuppone competenze multidisciplinari che uniscono architettura, botanica e ingegneria, rendendolo meno accessibile in contesti con risorse economiche o know-how limitati.
Un futuro da coltivare insieme
Il design biofilico, dunque, è molto più di una pianta in un angolo dell’ufficio o di una parete verde su un grattacielo. È un linguaggio progettuale che intreccia biologia e architettura, neuroscienze e design puntando a creare spazi che risuonano con i ritmi naturali dell’essere umano. Questa disciplina mira a risvegliare i sensi, le percezioni e il benessere psicofisico attraverso la presenza e la connessione con elementi naturali quali acqua, aria e vegetazione. In un’epoca in cui trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, il bisogno di riconnettersi con il mondo naturale si fa sempre più urgente: è un tentativo di cucire lo strappo che l’urbanizzazione ha inflitto alla nostra esistenza.
Architetti e progettisti hanno oggi una responsabilità che va oltre il mero costruire: possono creare ambienti, spazi e città che nutrono l’essere umano e affrontano l’urgenza del cambiamento climatico e la crisi ambientale. Ed è proprio in questo equilibrio, tra estetica, funzionalità e vita il filo verde della riconnessione con la natura espresso dal design biofilico.

Chiara Piacentini
Laureata in Scienze della Comunicazione, lavora come project manager nel settore pubblico, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dell’interazione tra cittadini e istituzioni, alle nuove tecnologie, all’accessibilità e all’inclusione. Appassionata di arte, architettura e design, è stata finalista al concorso nazionale di scrittura Architettura di parole, I° edizione.